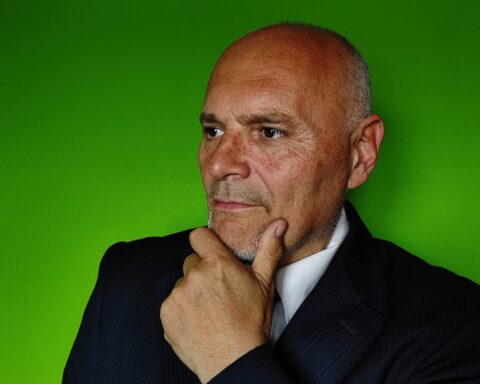Pur in presenza di un mercato del lavoro più salutare delle attese anche a giugno, il presidente americano Donald Trump è tornato a reclamare un cambio di direzione alla Federal Reserve. La pressione su Jerome Powell è massima e quasi certamente il governatore non otterrà il terzo mandato dopo la scadenza nel 2026. Il tycoon pretende niente di meno che i tassi di interesse scendano all’1%. Da dicembre sono fermi al range 4,25-4,50%. In pratica, vorrebbe che il costo del denaro scendesse ben al di sotto dello stesso livello dell’inflazione, che ancora nel mese di maggio era al 2,4%.
Tassi 1% come svalutazione del dollaro
C’è una logica dietro a tutto questo. I dazi servono a riportare in equilibrio la bilancia commerciale, spingendo i consumatori americani a preferire le produzioni nazionali al posto delle importazioni dall’estero.
Se a questo si aggiunge un dollaro più debole, l’effetto sostituzione risulta accentuato. E’ quanto sta già accadendo in questi mesi con il cambio in picchiata e le tariffe doganali ai massimi da decenni. Tuttavia, è ancora presto per tirare le somme sull’import/export. Anzi, in genere il saldo commerciale in valore accusa un peggioramento iniziale dopo una svalutazione o un aumento dei dazi.
Cosa c’entrano i tassi all’1%? Nella testa di Trump, sono il modo principale per tendere alla svalutazione del dollaro. Egli intuisce che altrove i tassi, pur in calo, scenderanno a livelli pur sempre superiori all’1%. Dunque, la politica monetaria USA diverrebbe relativamente più accomodante. A farne le spese sarebbe il dollaro, contribuendo al rilancio della competitività nazionale.
Problema inflazione
Quello che Trump finge di ignorare è che i dazi portano inflazione. Paradossalmente, sta rendendo più difficile il lavoro di Powell per tagliare i tassi; e non all’1%, ma anche solo di un altro 0,25%. Ignoranza sul funzionamento dell’economia? Difficile credere che nessuno nel suo “inner circle” capisca cosa stia facendo. Dietro c’è una grande scommessa: spingere gli americani ad accelerare il più velocemente possibile la transizione verso un sistema più autarchico. Se la sostituzione delle importazioni avverrà in breve tempo, i rincari avranno effetti limitati sui bilanci familiari. I consumatori si saranno già spostati sulle produzioni domestiche.
Il problema non sarebbe, però, sanato. Produrre negli USA è più costoso che praticamente in qualsiasi altra economia al mondo. L’inflazione uscirebbe dalla porta per rientrare dalla finestra. E con effetti strutturali. I tassi all’1% servirebbero a sostenere i prestiti ad imprese e famiglie per superare la fase di rodaggio, accrescendo consumi e investimenti. Già oggi, tuttavia, i primi costituiscono ben il 70% del Pil americano. La superpotenza si regge sulla domanda interna e un eventuale taglio dei tassi sconsiderato aggraverebbe le distorsioni. Basti pensare a quanto avvenne nel 2008 dopo anni di tassi all’1% sotto l’amministrazione Bush e con la FED costretta successivamente a recuperare alzando i tassi velocemente e provocando una grave crisi mondiale.
Debito pubblico più costoso?
C’è un altro motivo per cui Trump chiede tassi all’1%. Potrà così finanziare l’immenso debito pubblico da oltre 36.000 miliardi di dollari a basso costo. Se non fosse che ciò sarebbe vero per le scadenze medio-brevi. I rendimenti dei Treasury a 10, 20 o 30 anni dipendono dalle aspettative d’inflazione, oltre che dalla politica fiscale. Nel migliore dei casi, non risentirebbero dei tagli. Nel peggiore, salirebbero ulteriormente sul timore che bassi tassi insieme ai dazi favoriranno la ripresa dell’inflazione.
Tassi 1% senza benefici tangibili
Da quando la FED ha iniziato a tagliare i tassi nel settembre scorso (-1% cumulato), il Treasury a 10 anni offre lo 0,80% in più. E’ l’esempio più immediato per spiegare che i rendimenti lunghi non si muovono necessariamente nella stessa direzione dei tassi, né della stessa entità. A quel punto, Trump rischia di provocare solo effetti collaterali senza benefici percettibili per l’economia americana. Emetterebbe il debito allo stesso costo di prima, se non di più; il dollaro perderebbe credibilità sui mercati internazionali e il potere di acquisto per i consumatori americani si ridurrebbe. Senza che sia detto che l’industria americana aumenti la produzione. Per farlo dovrebbe importare materie prime e semi-lavorati dall’estero, ma con un cambio più debole risulterebbe difficile vendere i manufatti ai clienti locali. E sarebbe anche recessione.
giuseppe.timpone@investireoggi.it