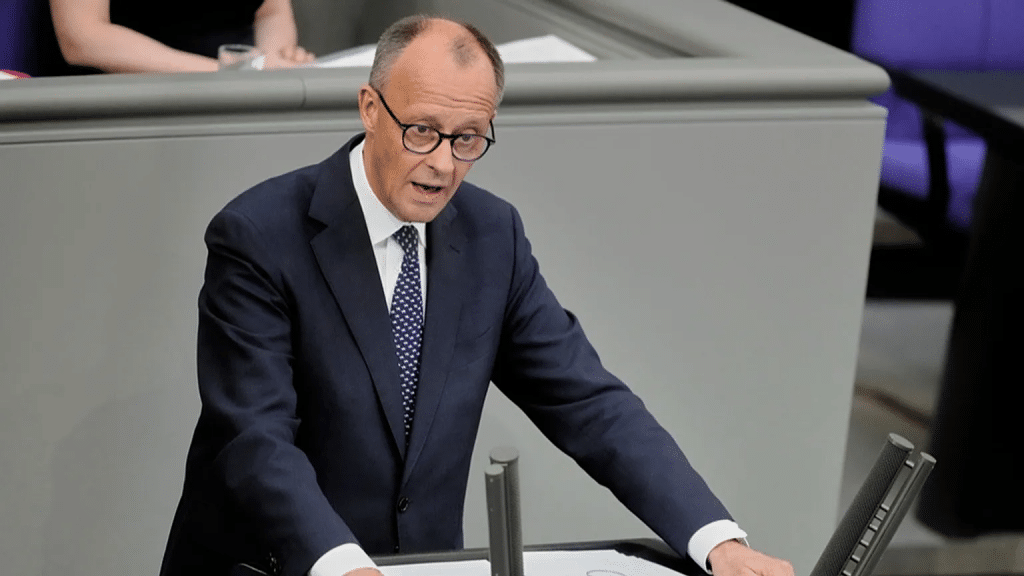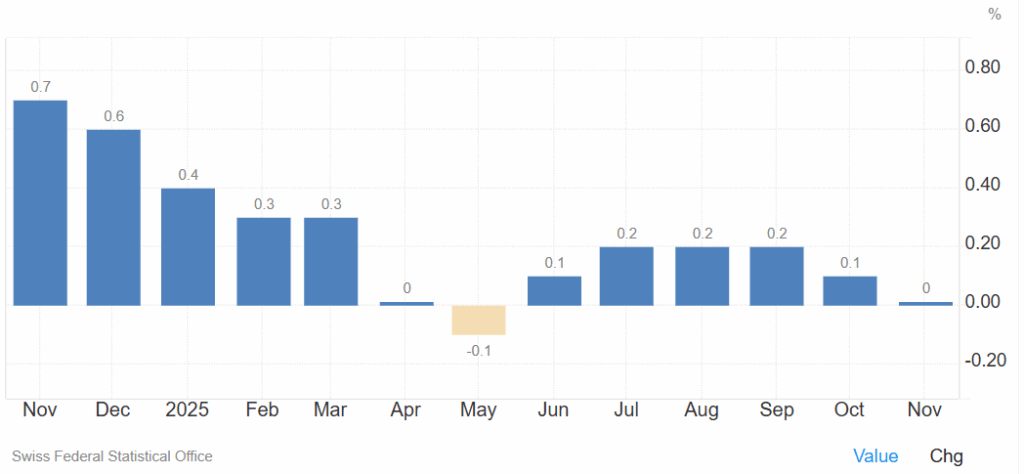Qualche giorno fa, vi abbiamo dato la notizia sulla riforma in vista per le OPA (Offerta Pubblica di Acquisto) nella parte in cui si stabiliscono le soglie per far scattare il lancio dell’offerta sul capitale rimanente. Una novità che porterebbe a una maggiore contendibilità del controllo societario in Italia. Si tornerebbe alla “legge Draghi” del 1998 e contenuta nel Testo Unico per la Finanza (TUF). Un’altra novità riguarderà presto i piccoli azionisti, sempre che passerà indenne il voto del Parlamento. I media l’hanno definita norma contro “i disturbatori”. Di cosa si tratta? Alle assemblee degli azionisti potranno parlare solo coloro che posseggono almeno lo 0,1% del capitale con diritto di voto.
Soglia-limite di 0,1%
Qual è la ratio di questa riforma? Impedire che un gran numero di piccoli azionisti prenda la parola per intralciare i lavori dell’assemblea in maniera pretestuosa. Sembrerebbe una novità positiva, andando nel segno della riduzione dei tempi per un’assemblea. Invece, si rivela persino di dubbia costituzionalità. A primo acchito lo 0,1% sembra pochissimo, ma in valore assoluto può significare anche decine di milioni di euro. Pensate a Unicredit o Intesa Sanpaolo, che in borsa valgono più di 100 miliardi di euro ciascuna. Se passasse la riforma, potrebbero prendere la parola solamente i soci in possesso di titoli per un controvalore di almeno 100 milioni. Insomma, i soliti noti.
Public company modello più lontano
Tralasciando i valori in gioco, il punto è preliminarmente un altro: i piccoli azionisti non sono gente che in assemblea per disturbare. Sono portatori di interessi, investitori che alimentano il mercato dei capitali. Senza di loro, le grandi famiglie del capitalismo italico se la canterebbero e suonerebbero da sole.
Limitare loro il diritto di parola equivale a impedire ad un cittadino che paga le tasse di manifestare il proprio pensiero. La riforma renderebbe i piccoli investitori soci menomati anche dal punto di vista formale. Per la serie, “caccia fuori i soldi e zitto!”. E poi a che pro? Non si è mai sentita una lamentela dei vertici aziendali per la lunga durata delle riunioni o per la scarsa qualità degli interventi. Parliamoci con franchezza: sono relativamente pochi coloro che partecipano e prendono la parola all’infuori dei grandi soci.
Certo, gli escamotage per superare il divieto si troverebbero. Basterebbe che un gruppo di piccoli azionisti delegasse uno di loro per poter partecipare ai lavori. Ovviamente, a patto di raggiungere il suddetto 0,1%. In ogni caso, andrebbe a farsi friggere l’idea delle “public company“, che in Italia sono sempre state mal viste. Sono le società quotate in borsa senza grandi soci a controllarle. Basta spesso un capitale modesto per spostare gli equilibri. E le assemblee servono quali occasioni di confronto per tirare la votazione da una parte all’altra. Infine, mettiamoci nei panni di chi investe anche tutti i propri risparmi in borsa. Saranno poche decine di migliaia di euro. Quisquilie per una quotata, ma tanta roba per l’interessato a cui vorremmo negare di dire la sua.
Piccoli azionisti malvisti dal capitalismo familiare
Quando parla un piccolo azionista, i grandi se ne sbattono. Tuttavia, non è detto che resti inascoltato tra gli altri piccoli azionisti come lui. Bisognerebbe essere chiari e dire una volta per tutte che noi un capitalismo diffuso non lo vogliamo, che preferiamo che le società restino sempre in mano ai fondatori e/o ai grandi soci. Sarebbe più onesto. Ma non possiamo passare le giornate a lamentarci di quanta scarsa sia l’educazione finanziaria tra gli italiani, pretendere che investano di più in borsa, meglio se italiana, ma allo stesso tempo trattarli da beoti. Se il capitalismo deve restare un club per poche famiglie (squattrinate), non disturbino i presunti disturbatori.
giuseppe.timpone@investireoggi.it